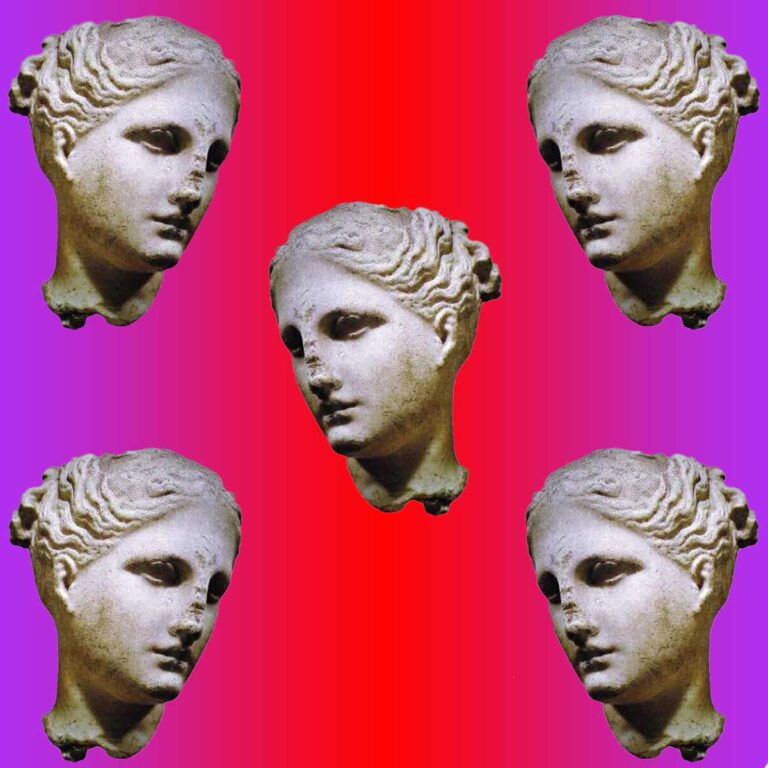Tra la prima e la seconda guerra mondiale non era facile sbarcare il lunario, nelle famiglie numerose il primogenito, anche se ancora adolescente, doveva industriarsi per aiutare, affinché i fratelli più piccoli avessero di che sfamarsi e, magari, potessero andare anche a scuola.
Ci si accontentava dei lavori più disparati, i più intraprendenti si proponevano come aiuto in qualche fabbrica, magari introdotti da un parente e, sgomitando e sudando, riuscivano ad affermarsi.
A Napoli, in quegli anni, vi era la Cristalleria Nazionale, discendente diretta di quella voluta da re Carlo III di Borbone, con sede nell’edificio precedentemente destinato al vecchio Ufficio giudiziario e che occupava parte dell’arenile di Castellammare di Stabia.
L’ubicazione del nuovo stabilimento, inaugurato nella prima metà del ‘700, fu determinata dalla qualità della sabbia del litorale in quanto, secondo gli esperti dell’epoca, risultava essere di un tipo più fine rispetto addirittura a quella di Venezia, il che avrebbe permesso di eguagliare i prodotti provenienti dalla Boemia. L’industria diventò molto fiorente e, nei secoli seguenti, fu spostata nel capoluogo.
Oltre ai maestri vetrai, vi era bisogno di un numero cospicuo di ragazzi, il cui compito consisteva nell’alimentare il fuoco nella fornace e la cui aspirazione era assumere ruoli di sempre maggiore rilevanza e responsabilità. Fu in questo modo che mio padre, appena quindicenne, cominciò il suo percorso fatto di sveglie ad orari improponibili e lunghe pedalate notturne per raggiungere la sede.
Tra gli oggetti a me più cari vi è una ceneriera di cristallo molata, uno dei rari pezzi rimasti di quando lui, giovane apprendista, si cimentava nell’arte del vetro.
Mia nonna, da buona massaia e madre amorevole, si levava anzitempo per poter preparare la gavetta e, sulla soglia, salutare e formulare un favorevole auspicio a quel suo primo figlio che, instancabile lavoratore, contribuiva ai bisogni quotidiani della famiglia:
Va’, ʹa Maronna t’accumpagna