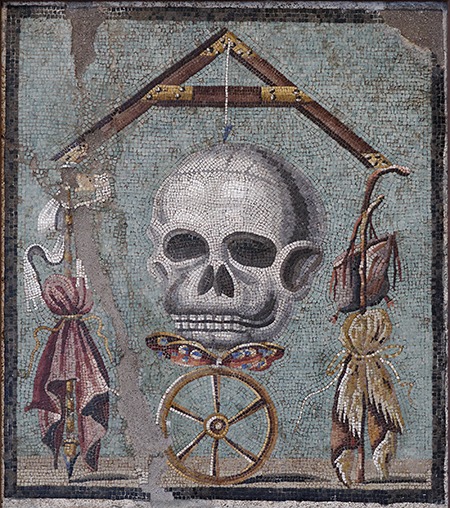Torrone, anime pezzentelle, il culto dei morti a Napoli non si racchiude nei soli pochi giorni di inizio novembre, ma è qualcosa di vivo, che si respira continuamente in una città dove tutto non si ferma alla semplice apparenza.
Ogni cosa ha un significato profondo, quasi nascosto a coloro che non pongono attenzione, ma che si perpetua e tramanda nei secoli.
Dopo anni d’oblio, esattamente il 5 aprile del 2019, grazie all’associazione Respiriamo Arte, ritorna in luce la chiesa di Santa Lucianella, chiusa a causa del terremoto del 1980, il cui ipogeo racchiude, oltre all’affresco del XVIII secolo della deposizione di Cristo rinvenuto coperto da quello delle anime purganti, una singolare scoperta: un teschio con le orecchie.

Nel cuore pulsante del centro storico troviamo un vico che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno che, nella Napoli greco – romana, si distingueva come Vicus Cornalianus.
All’epoca di Roberto d’Angiò, un suo giureconsulto di nome Bartolomeo di Capua, nel 1327, fonda la Chiesa di Santa Lucianella in pieno stile gotico, che, in seguito verrà indicata come la Cappella dell’Arte dei Mulinari, una confraternita che raggruppava mugnai e tutti coloro che lavoravano presso mulini.
Le trasformazioni non hanno sosta, nel 1508 diverrà il luogo di culto di una delle più potenti e importanti arciconfraternite partenopee: la segreta Corporazione dei mastri pipernieri, tagliamonti e fabbricatori.
A loro si devono innumerevoli opere, tra le quali la maestosa facciata bugnata della chiesa del Gesù Nuovo, sulla quale, ancora oggi, circolano diverse leggende intrise di mistero ed esoterismo.
Come ben si immagina, lavorando la pietra vulcanica con scalpello e martello, erano esposti alle ferite che le pietre appuntite infliggevano alla pelle, poca cosa nei confronti di una scheggia che si conficca in un occhio, provocando la cecità.
Ecco che nasce il culto della santa protettrice della vista, Lucia, i cui simboli sono tuttora presenti all’interno della cappella, mentre, sul portale d’ingresso in piperno, ai due lati, è ben visibile lo stemma della Corporazione.
Durante il XVIII secolo, come quasi tutte le chiese, viene rimaneggiata, risentendo fortemente dello stile Barocco, restando, in ogni caso, la sede dell’arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo dei Pipernieri.