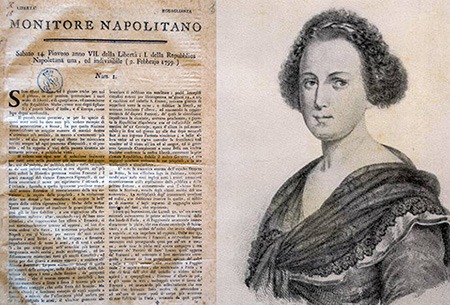Gli anni del secondo dopoguerra a Napoli furono caratterizzati da fame e povertà senza pari.
In ogni vicolo ci si arrangiava alla meno peggio, tanto che divenne uso comune cercare di placare i morsi della fame con ingredienti di scarto, come i baccelli vuoti di fave o piselli.
Per provare a reperire pasta, uova o un pochino di sugna bisognava industriarsi in ogni modo. Mia nonna Rosa chiedeva a mio padre, appena quindicenne, ma già maturo e responsabile, come tanti in quegli anni difficili, di salire in sella alla bicicletta per cercare di accaparrarsi qualcosa per il pranzo della famiglia.
Nonostante gli sforzi, ciò che si riusciva a trovare era sempre poco e, poiché la necessità aguzza l’ingegno, quando di sera le famiglie si riunivano intorno al desco, per tentare di distogliere l’attenzione dalla scarsità di cibo a disposizione, si diffuse l’abitudine, tra i singoli componenti del nucleo familiare, di raccontare le peripezie della giornata, arricchendole, magari, con tanta fantasia in modo da perseguire con maggiore efficacia l’intento.
‘Onna Ma’ o ssaie ca’ sotta ‘a cchiesa ro’ Carmene ai Mannesi è asciuta ‘na cosa antica?
Proprio così, a seguito dei massicci bombardamenti che nel ’43 ebbero la città di Napoli come obiettivo privilegiato, in una traversa di via Duomo, tra via San Biagio dei Librai e via dei Tribunali, esattamente a vico I Carminiello ai Mannesi, ritornò alla luce un complesso archeologico databile intorno alla fine del I secolo d.C. che includeva anche un piccolo edificio termale, in realtà un vero e proprio mitreo.